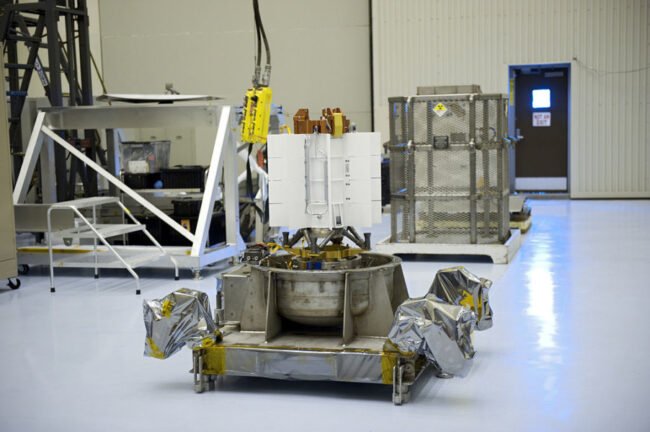L’energia nucleare a supporto della decarbonizzazione
Pubblichiamo di seguito la versione italiana del Position Paper di Nuclear for Climate in vista della conferenze delle Nazioni Unite sul Clima (COP26) che si terrà a Glasgow il prossimo novembre. La versione originale in inglese è scaricabile in calce. Ringraziamo Giuseppe Canzone per la redazione del testo in italiano e per le note esplicative. Net Zero Needs Nuclear -Position paper 2021 Nuclear for Climate è un’iniziativa che parte dal basso e che riunisce professionisti e scienziati del settore nucleare di oltre 150 associazioni. L’obiettivo di Nuclear for Climate è di instaurare un dialogo con i responsabili politici e il pubblico sulla necessità di includere l’energia nucleare tra le soluzioni “carbon free” atte a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Auspichiamo un futuro prospero per tutti, in cui le attività umane siano a basse emissioni di carbonio e sostenibili. La nostra missione è accelerare la capacità del mondo di raggiungere la decarbonizzazione [del sistema energetico, ndr] entro il 2050, promuovendo la collaborazione tra il settore nucleare e le tecnologie alla base delle fonti di energia rinnovabili. Crediamo nello slogan “Net Zero Needs Nuclear“ per questi motivi: ➢ L’energia nucleare è una fonte di energia a basse emissioni di carbonio: è comprovato che l’energia nucleare sia una fonte di energia a basse emissioni di carbonio che non solo può contribuire a ridurre le emissioni di gas serra ma è in grado di sostituire efficacemente la nostra attuale dipendenza energetica dagli inquinanti combustibili fossili. ➢ L’energia nucleare è allo stato dell’ arte, disponibile, scalabile e dispiegabile: per raggiungere l’ obiettivo di decarbonizzazione del sistema energetico (Net Zero) è necessario che nuove centrali elettronucleari siano dispiegate su vasta scala e con urgenza, in sinergia con le fonti energetiche rinnovabili [in particolare con l’idroelettrico, ndr]. ➢ L’energia nucleare è una fonte di energia pulita, flessibile e conveniente: il nucleare può integrarsi con le fonti di energia rinnovabili, bilanciando le fonti intermittenti [e utilizzando l’idroelettrico come sistema principale di accumulo] per ottenere sistemi energetici puliti, efficienti e convenienti. ➢ Il nucleare non fornisce soltanto elettricità a basse emissioni di carbonio: il nucleare è anche in grado di supportare la decarbonizzazione di altri settori economici (industria e servizi). ➢ Il nucleare sostiene lo sviluppo globale, inclusivo e sostenibile: il nucleare porta benefici socioeconomici globali che sono congruenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. A cinque anni dalla firma dell’Accordo di Parigi, ci stiamo rendendo conto dell’enormità della sfida che il mondo deve affrontare per limitare l’aumento della temperatura globale di 1,5 °C. La situazione climatica globale è critica e dobbiamo lavorare insieme se vogliamo raggiungere l’ambizioso obiettivo della decarbonizzazione [del sistema energetico, ndr] entro il 2050 e proteggere il futuro del nostro pianeta. Le strategie finora adottate non si sono rivelate efficaci mentre il 2050 si avvicina sempre più. Quindi dobbiamo agire ora. La conferenza COP26 di Glasgow rappresenta un’opportunità fondamentale per le nostre nazioni di riunirsi e agire [in modo coordinato, ndr], è necessario acquisire una visione comune sui problemi climatici [e ambientali, ndr] per trovare un strategia di intervento per raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione (Net Zero). Chiediamo a tutti i negoziatori e ai responsabili politici che parteciperanno alla COP26 di adottare un approccio neutrale dal punto di vista tecnico-scientifico verso quelle politiche energetiche favorevoli ad una integrazione tra energia nucleare e fonti energetiche rinnovabili. L’energia nucleare è una fonte di energia a basse emissioni di carbonio: è comprovato che l’energia nucleare sia una fonte di energia a basse emissioni di carbonio che non solo può contribuire a ridurre le emissioni di gas serra ma è in grado di sostituire efficacemente la nostra attuale dipendenza energetica dagli inquinanti combustibili fossili. Da oltre 60 anni il nucleare è una delle principali fonti di energia a basse emissioni di carbonio. Con circa 440 reattori in funzione in 30 paesi diversi, il nucleare rappresentava, alla fine del 2019, il 10% della produzione mondiale di elettricità. È la seconda più grande fonte di energia a basse emissioni di carbonio, dopo l’energia idroelettrica. La “carbon intensity” di una centrale nucleare, ovvero la quota di CO2 emessa da una centrale nucleare rispetto all’energia fornita, durante tutta la sua vita operativa, è molto bassa dello stesso ordine di grandezza di quelle dell’energia eolica e idroelettrica. I paesi a più bassa carbon intensity sono quelli nel cui mix energetico è presente una grande componente di energia nucleare e idroelettrica. La Francia, che produce circa tre quarti della sua energia elettrica da fonte nucleare, ha le emissioni di CO2 pro capite più basse tra i sette maggiori paesi industrializzati (G7). Utilizzando l’energia nucleare come fonte primaria, in sostituzione dei combustibili fossili, è stato possibile, a partire dal 1970, evitare l’immissione in atmosfera di un quantitativo di gas serra pari a 60 miliardi di tonnellate equivalenti di CO2. L’utilizzo del nucleare in luogo dei combustibili fossili è servito a prevenire circa 1,84 milioni di morti legate all’inquinamento atmosferico e si stima che altri 7 milioni di morti potrebbero essere evitati entro il 2050 se il nucleare sostituisse le fonti di combustibili fossili su larga scala. Nonostante l’impressionante crescita globale (circa il 500%) del solare e dell’eolico tra il 2000 e il 2018, l’uso dei combustibili fossili è rimasto costante, rappresentando circa l’80% dell’energia consumata a livello mondiale. Ciò è correlato ad un calo della quota del nucleare nel mix energetico nello stesso periodo di tempo, anche se la produzione nucleare in termini assoluti è aumentata. I Paesi che negli ultimi anni hanno deciso la chiusura delle loro centrali nucleari hanno incontrato difficoltà a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili [in particolare per quanto riguarda la generazione elettrica, ndr]. In Germania, a seguito di una graduale eliminazione del nucleare, la quota percentuale di combustibili fossili come fonte di energia primaria è diminuita di meno dell’1% dal 2010 nonostante i massicci investimenti (178 miliardi di euro) a sostegno delle fonti rinnovabili [in particolare eolico e fotovoltaico, ndr]. L’energia nucleare è allo stato dell’ arte, disponibile, scalabile e dispiegabile: per raggiungere l’obiettivo di decarbonizzazione…