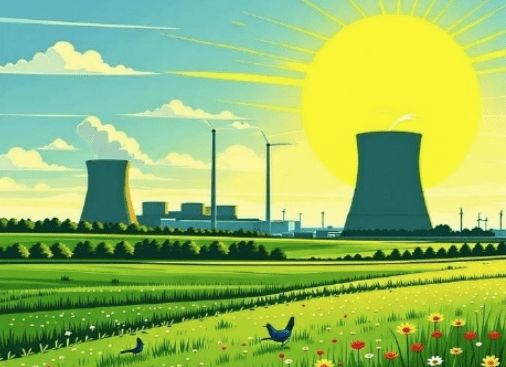Recenti eventi internazionali rilevanti e ripercussioni sull’attuale dibattito in Italia in tema di Energia Nucleare
Contributo dell’Associazione Italiana Nucleare (AIN) – Aprile 2024
Negli ultimi mesi due rilevanti eventi a livello internazionale – in buona parte condizionati dalle gravi crisi geopolitiche in corso che hanno brutalmente ricordato ai decisori politici ed ai cittadini i rischi di dipendenza energetica da paesi ‘critici’ e il grave impatto su tutti i settori industriali e sulla vita quotidiana – hanno radicalmente cambiato l’atteggiamento dei paesi occidentali nei confronti dell’energia nucleare, evidenziandone il ruolo fondamentale per la decarbonizzazione e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Tutto ciò sta avendo notevoli ripercussioni anche nell’attuale dibattitto italiano sulla definizione del più appropriato mix energetico nazionale nel medio e lungo termine.
Per la prima volta la Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici (cosiddetta COP) – tenutasi nel dicembre 2023 a Dubai – nel cosiddetto “First Global Stocktake, ovvero nel documento che valuta a che punto è il mondo rispetto al conseguimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi del 2015, è stata inserita l’energia nucleare, insieme alle fonti rinnovabili e alla cattura, utilizzo e sequestro della CO2. Nell’ambito della stessa COP-28 di Dubai, 25 paesi, riconoscendo l’energia nucleare come elemento chiave per il raggiungimento dell’obiettivo di contenere l’incremento della temperatura globale entro 1,5°C, hanno siglato un impegno a triplicare la capacità nucleare entro il 2050.
Ancora più rilevante per l’Italia è stata la dichiarazione dei 37 paesi che hanno partecipato e contribuito al primo Nuclear Energy Summit svoltosi a Bruxelles sotto l’egida dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) delle Nazioni Unite e del Governo del Belgio, un paese che fino a poco tempo fa aveva dichiarato di volere uscire completamente dal nucleare. In maniera assai pragmatica questi 32 paesi – incluso l’Italia – hanno riconosciuto che l’ambizioso obiettivo di zero emissioni nette all’orizzonte del 2050 richiede un approccio globale per ridurre drasticamente quelle derivanti dai settori a più alta intensità di emissioni, tra cui la produzione di elettricità, i trasporti e l’industria. Riconoscendo che l’energia nucleare è una fonte primaria a zero emissioni affidabile e programmabile, i paesi firmatari hanno riaffermato il loro forte impegno nei confronti del suo esteso utilizzo come componente chiave della strategia globale per ridurre le emissioni di gas serra sia del settore energetico sia di quello industriale, al fine di garantire e migliorare la sicurezza e la resilienza energetica e promuovere lo sviluppo sostenibile a lungo termine. In pratica l’energia nucleare viene riconosciuta come fonte energetica primaria essenziale per assicurare la transizione verso sistemi energetici sicuri e completamente decarbonizzati.
L’impegno sopra menzionato si tradurrà in maniera operativa nel sostegno, anche finanziario, all’estensione di vita degli impianti nucleari esistenti, alla costruzione di nuove centrali nucleari e al rapido dispiegamento di reattori avanzati, compresi i piccoli reattori modulari, mantenendo i più alti livelli di sicurezza e protezione dell’ambiente e delle popolazioni.
E’ interessante notare che fra le misure concrete a sostegno dell’energia nucleare i 37 paesi firmatari includono strumenti di supporto finanziario come partecipazione diretta di capitali pubblici, garanzie pubbliche ai fornitori di debito e capitale, schemi di condivisione dei rischi finanziari a fronte di condivisone degli utili. Nella dichiarazione ci si spinge fino a chiedere l’inclusione dell’energia nucleare nelle politiche ambientali, sociali e di governance (ESG) del sistema finanziario internazionale, un cambiamento che potrebbe rivoluzionare il supporto finanziario ai progetti nucleari considerati sostenibili e che mirino alla decarbonizzazione della nostra società.
Una questione correlata alla precedente portata al tavolo della discussione sia dai due eventi internazionali sopra citati, sia da altri eventi europei quale la giornata di lancio della European SMR Industrial Alliance avvenuta lo scorso 22 marzo a Bruxelles alla presenza di tre commissari europei è che notoriamente i progetti nucleari sono ad alta intensità di capitale e richiedono ingenti investimenti iniziali. Soprattutto nel caso di impianti nucleari di grande taglia, sono necessari rilevanti investimenti in conto capitale ben prima che si possano generare entrate dalla produzione di energia. Un approccio di condivisione del rischio che coinvolga la futura utility, il possessore della tecnologia (vendor), i potenziali utilizzatori finali e lo Stato potrebbe ridurre significativamente i rischi legati agli investimenti iniziali e migliorare la sostenibilità economica dei nuovi progetti nucleari, anche nel mondo occidentale. Senz’altro nuove tecnologie quali gli SMR (Small Modular Reactors) e gli AMR (Advanced Modular Reactors) basate sulla modularità, fabbricazione in officina ed economia di produzione in serie favoriranno ulteriormente questo approccio.
Considerata la rilevanza per il nostro Paese degli eventi internazionali sopra citati e delle relative dichiarazioni ufficiali, è opportuno valutarne le implicazioni sul nostro sistema energetico e industriale, almeno in prospettiva e in chiave europea.
La prima e più immediata considerazione è il riconoscimento che le rinnovabili sono e saranno un elemento fondamentale per la transizione energetica ma da sole non possono risolvere la difficile equazione di un sistema energetico completamente decarbonizzato e sostenibile anche dal punto di vista economico. Tutti i paesi che hanno siglato le dichiarazioni pro-nucleare a COP28 e al Nuclear Energy Summit hanno ambiziosi programmi di espansione delle energie rinnovabili ma tutti riconoscono che da sole non saranno in grado di raggiungere gli obiettivi di net zero al 2050. Tantomeno sarà possibile per i Paesi europei ora che la Commissione Europea ha fissato obiettivi intermedi al 2040 ancora più sfidanti, quale la riduzione delle emissioni di gas climalteranti del 90% al 2040 rispetto al 1990, per raggiungere il quale – non a caso – la stessa Commissione Europea ribadisce che tutte le tecnologie energetiche a zero o basse emissioni di carbonio, incluso il nucleare, sono necessarie.
L’altra osservazione rilevante è che anche l’Italia, sebbene al momento non dotata di impianti nucleari di potenza, riconosce l’importanza di mantenere in esercizio e in sicurezza le attuali centrali nucleari, che nella sola Europa garantiscono quasi il 25% della domanda elettrica e circa la metà di quella decarbonizzata. Si riconosce altresì la necessità di costruire nuovi impianti non solo per la generazione elettrica, che in Europa è data in rapida crescita (triplicazione in circa 30 anni) per coprire un largo spettro dei consumi finali, ma anche per i cosiddetti settori hard-to-abate che potranno vedere nell’idrogeno, prodotto anche per via nucleare, un importante vettore energetico complementare all’elettricità. A tale proposito va osservato che i 16 paesi europei che nel 2023 hanno dato vita alla Nuclear Alliance, alla quale al momento l’Italia partecipa come osservatore, stanno preparando una roadmap che permetta di raggiungere in Europa i 150 GWe di capacità nucleare nel mix energetico al 2050. Considerato che l’attuale flotta nucleare UE è composta da 100 reattori nucleari molti dei quali necessitano nei prossimi anni di estensione di vita, è ragionevole prevedere che da qui al 2050 la UE sarà impegnata su un centinaio di progetti nucleari, dapprima basati sui più moderni reattori ad acqua di grande taglia oggi disponibili (ne sono già stati annunciati svariate decine in tutta Europa) e successivamente, mano a mano che si affermeranno sul mercato, sui sopra citati reattori di tipo SMR (attesi dopo il 2030) e AMR (attesi dopo il 2040). Si tratta di un potenziale business di svariate centinaia di miliardi di euro dal quale il sistema industriale nucleare italiano non può e non deve rimanere fuori. La possibilità per la nostra industria nazionale di intercettare una parte considerevole di questo business è assicurata in primis dalle nostre capacità e competenze di livello internazionale nella catena di forniture industriali, molto apprezzate in Europa e nel mondo, integrate da quelle nella ricerca, nella formazione e nella gestione di progetti nucleari complessi. Tale situazione rappresenta una solida base per un’ampia partecipazione italiana ad iniziative e progetti nucleari all’estero, in particolare in Europa, con benefici attesi sul PIL e sulla occupazione, in particolare quella altamente qualificata, già dai prossimi anni.
In un contesto europeo che, come sopra osservato, prevede l’estensione di vita di almeno il 60% degli impianti nucleari attuali, l’avvio di significative realizzazioni di impianti nucleari avanzati in molti Paesi ed il lancio di importanti programmi di sviluppo per la definizione di nuovi tipi di impianti che ampliano le opportunità del mercato di domani, è necessario però muoversi rapidamente per aggiornare le strutture produttive alle nuove caratteristiche del mercato (e.g. produzione in serie di componenti, ricorso alle più avanzate tecniche di lavorazione, ecc.) ed ancor più per sviluppare adeguatamente le infrastrutture (e.g. impianti per prove prototipali, logistica delle materie prime e dei semilavorati, sistemi di test e collaudo). Sul fronte del supporto di R&S il Governo ha già compiuto uno sforzo significativo con la recente allocazione di rilevanti risorse finanziarie all’ENEA. In sinergia con queste risorse, andrebbe ora avviato un programma di valenza industriale capace di rendere ancor più competitiva l’industria nazionale nell’acquisizione di commesse all’estero e, in prospettiva, per le realizzazioni in Italia.
Come già avvenuto in altri Paesi europei che stanno riconsiderando l’opzione nucleare, sarebbe opportuno realizzare una hub industriale che permetta la rapida qualificazione e certificazione di prodotti e processi nel campo di: sistemi e componenti dell’isola nucleare, strumentazione e sistemi di controllo, apparecchiature meccaniche ed elettriche, ecc.. Tale hub potrebbe essere reso sinergico con realtà già esistenti nel nostro Paese come quelle di impianti sperimentali “freddi” (cioè non contenenti materiali nucleari) di caratura internazionale, che già supportano importanti programmi di R&S a livello europeo ed internazionale. In tal modo, il sistema nucleare italiano – facendo anche leva su accordi già siglati ad esempio con l’industria nucleare francese e rumena – potrebbe acquisire un crescente numero di commesse per realizzazioni all’estero e, nel contempo, prepararsi “sul campo” per le future realizzazioni in Italia.
Il supporto del Governo allo sviluppo del settore industriale, così come alla ricerca e alla formazione a tutti i livelli, andrebbe inoltre accompagnato da una più vasta ed efficace partecipazione a tutte le iniziative in campo internazionale ed europeo che nei prossimi anni consentiranno al settore nucleare di essere parte attiva e rilevante nella transizione energetica.
Già si è citata la European Nuclear Alliance alla quale l’Italia, al momento con stato di osservatore, dovrebbe partecipare come membro effettivo, proprio grazie alla strategia operativa sopra menzionata. Ugualmente rilevante, soprattutto per un Paese particolarmente interessato alle tecnologie nucleari innovative come gli SMR e gli AMR, è la partecipazione alla European SMR Industrial Alliance lanciata dalla Commissione Europea lo scorso febbraio, e aperta a tutte le organizzazioni pubbliche e private interessate a facilitare e accelerare lo sviluppo, dimostrazione e utilizzo dei primi SMR in Europa all’orizzonte del 2030. Considerato lo specifico interesse italiano per I piccoli reattori modulari di tipo avanzato, sarà fondamentale assicurare l’ampia partecipazione delle industrie e delle organizzazioni nazionali, al fine di facilitare un altrettanto ampia partecipazione italiana alle catene di fornitura nucleari in Europa.
Oltre ai già ricordati benefici per l’Italia derivanti dal contributo alla decarbonizzazione del sistema energetico europeo, alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e all’acquisizione di commesse per realizzazioni di impianti nucleari all’estero con rilevanti ricadute sul PIL e sull’occupazione, vanno inoltre considerati altri vantaggi offerti da un programma di realizzazioni nucleari. Storicamente il nucleare è particolarmente labor intensive e richiede, soprattutto nella fase di pianificazione, progettazione, manifattura e costruzione una forza lavoro altamente qualificata. Durante l’esercizio della centrale sono richieste meno competenze di elevata professionalità, ma in numero elevato per unità di potenza installata. Un numero considerevole di lavoratori specializzati è anche richiesto per la gestione del ciclo del combustibile a valle (combustibile irraggiato e rifiuti radioattivi) nonché per la fase di smantellamento finale dell’impianto a fine vita (decommissioning), sui quali l’Italia ha già competenze e capacità di caratura internazionale.
Per fornire una idea di massima dell’impatto dell’energia nucleare sull’economia di una regione sviluppata come l’UE, che ha un parco centrali nucleari di circa 120 GWe, si consideri quanto segue (dati al 2019):
- Nella sola UE il settore nucleare supporta 1,1 milioni di lavoratori dei quali il 47% sono di elevata formazione e professionalità;
- Il PIL generato nell’Unione Europea dal settore nucleare è pari al 3-3.5% dell’intero PIL UE (più di 500 miliardi di Euro all’anno): ogni Euro di contributo dell’industria nucleare genera 4 Euro di contributi indiretti al PIL dell’Unione e quindi un impatto complessivo di 5 Euro sul PIL dell’UE;
- Nel 2019 il settore nucleare europeo ha generato 124 miliardi di euro di entrate pubbliche (tassazione);
- Ogni GWe installato in Europa genera: 4,3 miliardi di Euro di PIL, circa 10mila posti di lavoro di cui circa 4500 ad alta professionalità, 1 miliardo all’anno di entrate pubbliche.
In conclusione, come ribadito in vari consessi internazionali quali COP28 e Nuclear Energy Summit, e come raccomandato da tutte le agenzie internazionali (IPCC, OECD-IEA, OECD-NEA, IIASA, IAEA, UNECE) decarbonizzare l’intero settore energetico in modo economicamente vantaggioso garantendo, nel contempo, sicurezza di approvvigionamento a prezzi sostenibili, richiede la rapida disponibilità ed utilizzo di tutte le tecnologie energetiche a basso contenuto di carbonio.
L’energia nucleare è una sorgente primaria affidabile, programmabile e con alto tasso di disponibilità. E’ in grado di produrre in grandi quantità tutti i principali vettori energetici: elettricità, calore e idrogeno. Unitamente alle rinnovabili, l’energia nucleare si candida dunque a diventare la spina dorsale della transizione energetica in tutto il mondo. Se sarà capace di fare sistema con un coordinamento globale fra i diversi attori (utility, possessori di tecnologia, futuri clienti, operatori finanziari, ecc.), l’Italia con le sue capacità e competenze di livello internazionale e con un adeguato supporto dello Stato sarà senz’altro in grado di intercettare tutte le possibilità che si stanno aprendo nel settore nucleare nel mondo, in Europa e, in prospettiva, in Italia.