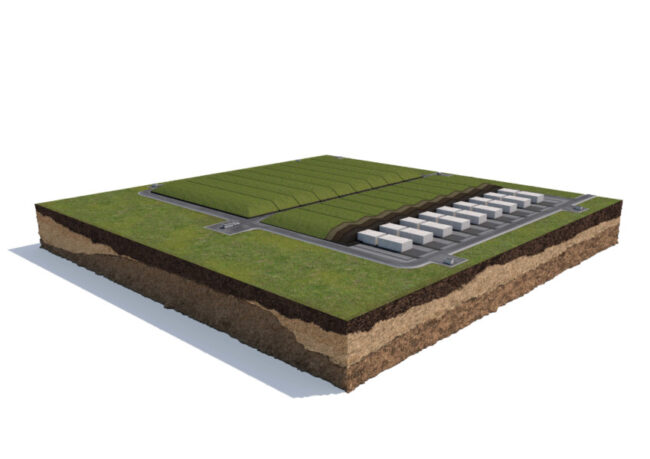AIN in audizione alle commissioni della Camera
Oggi 14 Marzo 2022 alle 15 il Presidente Minopoli ha partecipato in videoconferenza alle audizioni informali dalle commissioni VIII e X della Camera nell’ambito dell’esame del decreto-legge n. 17 del 2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Con grande soddisfazione riportiamo la notizia, sapendo che è solo uno dei passi necessari affinché il nostro Paese e l’Unione Europea tutta si dotino di un piano energetico che possa garantire stabilità nelle forniture e nei prezzi, basso impatto ambientale e sulla salute umana. Pubblichiamo quindi il testo integrale del nostro intervento Intervento di Umberto Minopoli, Presidente dell’Associazione Italiana Nucleare Il decreto si occupa dell’emergenza, ma intende anche porre le premesse per diversificare efficacemente il nostro sistema energetico, dopo la crisi dei prezzi, quella ucraina e nella prospettiva della transizione energetica. Noi suggeriamo, anche, la richiesta italiana di un recovery plan europeo, specifico, per l’elettricità. Va benissimo l’ipotesi di sganciare i prezzi dell’elettricità da quelli del gas di importazione. Ma deve valere anche per il futuro e, proponiamo, anche per l’energia elettrica europea prodotta da fonte nucleare. Quella esistente e quella in costruzione. Non basta solo diversificare le aree da cui importiamo beni energetici. Occorre anche diversificare le fonti con cui produciamo energia elettrica. E privilegiare le fonti interne. Serve un piano europeo per l’elettricità. Nucleare e rinnovabili rappresentano le fonti che, nel futuro, meglio potranno integrarsi per assicurare un sistema europeo sostenibile, resiliente e che garantisca approvvigionamenti sicuri, indipendenza e ottimizzazione della rete. Il nucleare è già oggi, in Europa, la prima fonte non carbonica nel mix elettrico dell’Unione. Gli investimenti nel nucleare, dunque, vanno considerati un’opportuna scelta europea. L’Italia, che importa energia nucleare per il 14% del suo fabbisogno, deve sostenere la decisione europea di ammettere il gas e il nucleare nella tassonomia delle fonti sostenibili. Le importazioni di energia elettrica dall’Europa, molto probabilmente, dovranno aumentare. Noi proponiamo che questo avvenga in nuove modalità che stabilizzino il prezzo dell’elettricità per famiglie e imprese. La nostra proposta è: partecipare direttamente agli investimenti europei in nuove centrali nucleari. La tassonomia, in questo, aiuta. Pensiamo a consorzi di utilizzatori, o a iniziative di utilities italiane e a filiere industriali nazionali che partecipino alla costruzione delle future centrali europee. Per ritirare energia da quelle centrali a prezzo di produzione e non di importazione. Il modello è l’accordo Enel-Edf del 2009 sulla centrale di Flamanville in Francia. Abortito dopo il referendum del 2011. Come associazione tecnico scientifica non suggeriamo, come fu con l’abbandono del nucleare, scelte emotive di nuove costruzioni nucleari oggi. Ma in una visione strategica di cambio del nostro mix energetico il problema si impone. E le premesse vanno messe. Associazione Italiana Nucleare propone alcune misure: un accordo europeo sull’import elettrico; la partecipazione alle nuove costruzioni nucleari europee, specie quelle ai nostri confini; la partecipazione alle iniziative nucleari europee: non solo ITER e la fusione nucleare (dove siamo protagonisti internazionali) ma anche il sicuro e nuovo nucleare da fissione (terza generazione avanzata, small reactors e quarta generazione); il recupero del mancato inserimento del nucleare nel PNRR inserendo la ricerca nucleare nel sistema ordinario della ricerca (al pari della scelta che il decreto energia indica per l’automotive); il sostegno (l’esempio è la legge che consentì all’Italia di costruire la terza industria aerospaziale europea) le imprese italiane che scelgono di partecipare alle iniziative nelle nuove tecnologie nucleari e in tutte quelle della transizione energetica, attraverso la ricerca, la manifattura o l’ingegneria; la realizzazione, finalmente, del Deposito Nazionale dei rifiuti nucleari. Grazie per l’opportunità, data oggi, ad una comunità, quella nucleare italiana, che è di tecnici, scienziati, accademici, imprese, ricercatori che rappresentano un punto di forza e prestigio del nostro Paese in Europa e nel mondo.