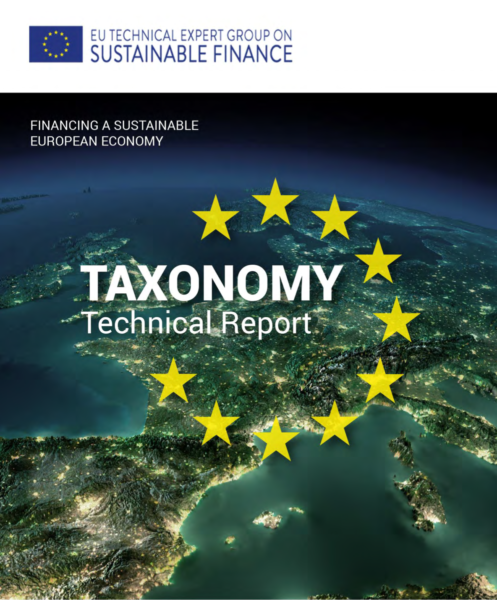L’Europa prende tempo ma la crisi energetica morde
Abbiamo atteso fino all’ultimo nella speranza di poter dare ai nostri lettori la bella notizia dell’inclusione dell’energia nucleare nella Tassonomia europea della finanza sostenibile. Eppure gli Atti Delegati, la cui presentazione al Parlamento di Strasburgo da parte della Commissione era attesa entro la fine dell’anno, sono stati, dopo una serie di anticipazione, di volta in volta rinviati. Le ultime indiscrezioni parlano di uno stallo creatosi a causa della mutata posizione del neo eletto governo tedesco, che avrebbe sconfessato accordi precedentemente presi tra Merkel e Macron. Serviranno dunque ancora settimane a raggiungere un accordo e poi passerebbero 4 o 5 mesi per l’entrata in vigore delle norme. Nel frattempo, la crisi energetica che attanaglia il vecchio continente sembra precipitare nell’indifferenza generale del governo dell’Unione, che ancora si illude trattarsi di una crisi temporanea, di pochi mesi, dovuta alla ripresa economica piuttosto che di una crisi strutturale. Ad ogni modo l’ormai certo inserimento dell’energia nucleare nella Tassonomia crea nervosismo negli ambienti antinucleari, con alcuni media italiani che fanno a gara con articoli quotidiani a screditare l’energia dell’atomo, avvalendosi delle motivazioni più strampalate, essendo il nucleare ormai non più attaccabile sotto il profilo tecnico-scientifico, come asseverato da numerosi organismi internazionali. E mentre il blocco anti-nucleare, composto da Danimarca, Germania, Austria e Irlanda mantiene salde le proprie posizioni minacciando azioni legali contro la decisione della Commissione, diversi segnali dimostrano come l’indispensabilità del nucleare sia tutt’altro che un mito. Primo fra tutti l’improvvisa chiusura per manutenzione straordinaria di 4 reattori francesi, che ha causato la perdita del 10% della capacita nucleare transalpina forzando la riattivazione di vecchie centrali ad olio combustibile e carbone, sulla scorta di quanto avvenuto già in precedenza in Italia causa la spinta al rialzo dei prezzi del gas naturale. Ma ci sono anche le notizie positive. Di pochi giorni fa la notizia che il governo olandese ha infatti deciso non solo di mantenere attiva la centrale nucleare di Borssele, ma ha anche stanziato 500 milioni di euro per la costruzione di due nuove centrali da qui al 2025. La Polonia, dove secondo i sondaggi il nucleare incontra il favore del 78% dei cittadini, ha nel frattempo individuato il primo sito dove sorgeranno i nuovi impianti nucleari. La Finlandia ha avviato l’unità 3 di Olkiluoto, il primo EPR del continente, che produrrà a regime circa il 14% del fabbisogno elettrico del Paese. Ma la vera notizia correlata all’avvio del reattore è la dichiarazione di apertura sul nucleare del movimento Fridays for Future finlandese, motivata dal fatto che la crisi climatica costituisce un rischio maggiore delle scorie nucleari. Per chiudere, la Bielorussia ha avviato il caricamento del combustibile nell’unità 2 di Ostrovets, che verrà connessa alla rete nei primi mesi del 2022, affiancando Ostrovets 1, che già produce il 22% dell’elettricità del Paese. La Bielorussia sta nel contempo elettrificando i consumi finali per ridurre sempre più il consumo di gas naturale, e dal 2024 integrerà la propria rete elettrica c on quella della vicina Russia. Anche fuori dall’Europa ci sono stati avvenimenti importanti: il primo reattore di quarta generazione (HTR-PM, un reattore modulare a gas ad alta temperatura) connesso alla rete in Cina (si avete capito bene, un reattore di IV generazione, quelli che secondo i giornali italiani non esistono); la decisione del fondo sovrano del Qatar di investire 85 milioni di sterline per aggiudicarsi una quota del 10% nella controllata di Rolls-Royce che costruirà gli Small Modular Reactors. Non resta che auspicare quindi che le feste portino consiglio e che facciano uscire la Tassonomia dalle sabbie dei contrapposti veti politici, ma soprattutto che insinuino, nel governo Europeo e in quelli dei Paesi membri, un barlume di visione strategica nel campo energetico che non è. più a nostro avviso procrastinabile.