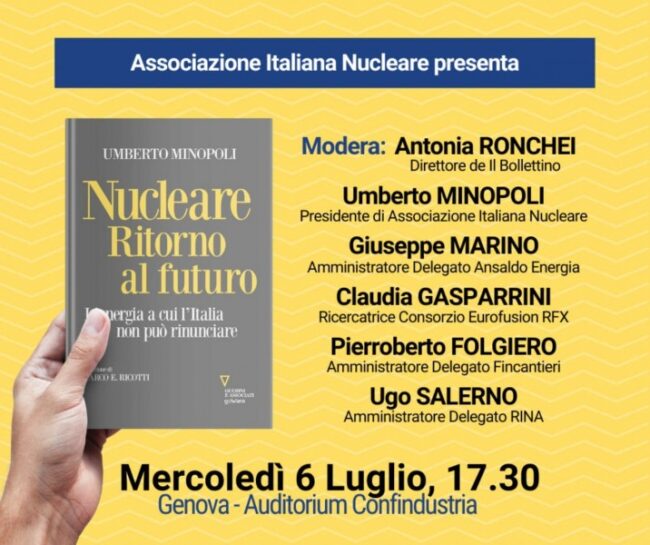DEMO: parte la progettazione ingegneristica
Il Consorzio EUROfusion, in occasione della conferenza di lancio di Horizon EUROfusion, ha annunciato che l’impianto dimostrativo di fusione nucleare DEMO (Demonstration Fusion Power Reactor) entrerà in funzione verso il 2050. Inizia quindi la progettazione ingegneristica dell’impianto, un passo avanti nella roadmap europea per portare la fusione dall’ambito puramente sperimentale alla produzione reale di energia elettrica. L’annuncio arriva dopo il risultato record di 59 MJ ottenuto nel JET (Joint European Torus) con deuterio-trizio: 11MW in 5 secondi, a fronte dei 33MW di potenza di riscaldamento immessa. In DEMO si userà deuterio-trizio come combustibile e si prevede una potenza elettrica alla rete di 500 MW. L’obiettivo infatti è 2000MW di potenza di fusione, che diventano circa 2400MW di potenza termica (a causa della moltiplicazione energetica nel blanket e del connesso riscaldamento del plasma), che risulta in circa 900MW di potenza elettrica – di cui 400MW è reimmessa nel sistema per mantenerlo acceso. Link al comunicato stampa Un po’ di chiarezza La fusione nucleare è il meccanismo che vediamo verificarsi nelle stelle, inverso alla fissione: anziché spaccare atomi pesanti, l’obiettivo è far fondere atomi leggeri (come gli isotopi dell’idrogeno) – liberando energia. Affinché gli atomi possano unirsi, è necessario portarli a temperature estremamente alte. In un tipo di macchina chiamato tokamak, il combustibile viene scaldato fino a che gli atomi si separano in ioni positivi e negativi, arrivando allo stato di plasma. Questo insieme di particelle cariche viene ‘intrappolato’, o meglio confinato, da un campo magnetico: in questo modo non tocca le pareti interne della macchina. Gli impianti a fusione funzionano quindi come un amplificatore di energia, e parte della dimostrazione sperimentale risiede appunto nel riuscire a verificare che riusciamo tecnologicamente ad estrarre maggiore energia di quanta ne immettiamo. Horizon EUROfusion è il nuovo programma europeo di ricerca sulla fusione cofinanziato dalla Commissione Europea tramite Euratom. EUROfusion comprende circa 4800 scienziati da istituzioni di 29 Stati: 26 UE, Svizzera, Regno Unito e Ucraina. Di questo fanno parte 21 organizzazioni italiane coordinate da ENEA, tra queste l’Istituto per la scienza e tecnologia dei plasmi del consiglio nazionale delle ricerche (CNR-ISTP) e il Consorzio RFX. EUROfusion per il 2021-2025 ha a disposizione oltre 1 miliardo di euro, di cui 550 milioni da Euratom. L’Italia, secondo partner più importante dopo la Germania, ne riceverà il 16%, circa 90 milioni. JET, ITER E DEMO… cosa cambia? Sono macchine simili, che incrementalmente ci avvicinano a sfruttare la fusione come fonte energetica. Riportiamo qui sotto alcuni parametri chiave Parameter JET (1997) JET (2021) ITER EU-DEMO Plasma radius 2.96 meters 2.96 meters 6.2 meters 9 meters Plasma volume 83 m3 79 m3 840 m3 2519 m3 Maximum plasma pulse duration 30 seconds, of which 5 seconds** at high power 30 seconds, of which 5 seconds** at high power 1000 seconds 2 hours Magnetic field 3.45 Tesla 3.45 Tesla 5.3 Tesla 5.9 Tesla Fusion power 16 MW heat 10-15 MW heat for 5 seconds** 500 MW* heat for more than 300 seconds (objective) 2000 MW of heat, 500 MW of electricity*** (objective) External plasma heating 24 MW heat 40 MW heat 50 MW heat 50 MW heat Performance (fusion power / external heating) 0.65 (realised) for 0.15 seconds, or 0.18 for 5 seconds** 0.25 to 0.375 for 5 seconds** (targeted) 10 (objective) 40 (objective) Produce electricity? No No No Yes First plasma 25 June 1983 << Dec 2025 ~2055 First tritium plasma 9 November 1991 (world’s first D-T plasma) << Dec 2035 ~2055 * As an experiment that runs for a limited amount of time per day, ITER will not turn its excess fusion heat into electricity. That would be possible using existing technology, but would also increase the cost and complexity of the facility. ** JET’s high energy plasmas are limited in duration by its copper electromagnets, which are not cryogenically cooled. Superconducting magnets used in ITER and EU DEMO can stay active for as long as needed. *** EU DEMO targets 2000 MW fusion power, which becomes about 2400MW thermal power (due to energy multiplication in the blanket, and the attached plasma heating), which becomes ~900 MW electrical power, which in turn becomes 500MW (target) electrical power to the grid (~400 MW is recirculated to run the plant systems).